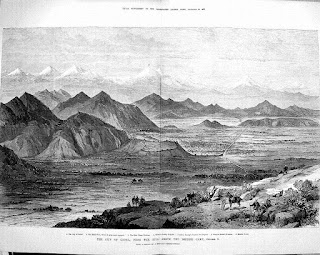A un anno dal ritiro del contingente Isaf Nato e dal suo ridislocamento e ridimensionamento nella missione Resolute Support, e a un pugno di mesi dalle elezioni presidenziali di aprile, l'Afghanistan è davanti a una svolta importante ma i nodi da sciogliere restano tanti. Complessi e per certi versi insormontabili.
Processo di pace
La riconciliazione nazionale sembra a un punto morto. L'apertura di un ufficio politico dei talebani a Doha, in Qatar, premessa di un possibile dialogo non ha dato i frutti sperati e ha anzi esacerbato le posizioni. Karzai e il suo Consiglio di pace, unico attore negoziale possibile per il governo di Kabul, si sono irrigiditi sia per il fatto che gli americani, scavalcando il governo afgano, hanno tentato di condurre trattative separate, sia per il fatto che il riconoscimento formale della delegazione all'estero è sembrato loro troppo rapido e in grado di fornire ai talebani un asso in più da giocare. L'unica novità sembra l'atteggiamento del Pakistan che ha ammorbidito i toni con l'arrivo del neo premier Nawaz Sharif e ha ottemperato ad alcune richieste di Kabul sulla liberazione dei prigionieri talebani (da utilizzare eventualmente come mediatori). Ma tutte le posizioni sembrano per ora distanti e ognuno (Islamabad, Washington, Teheran) più disposto a inseguire un risultato su altri fronti che non a dare manforte al governo legittimo perché la trattativa sia condotta su binari trasparenti e alla fine risolutivi.
Ritiro e sicurezza

La sicurezza del Paese continua a essere il grande tema che indebolisce la posizione del governo e quella della comunità internazionale - che non riescono a garantirla fuori dai grandi centri urbani – mentre il post 2014, col ridimensionamento del contingente Nato, appare agli afgani più una ritirata strategica e un problema di spesa e consenso interno che non una strategia in grado di aiutarli veramente. Italiani e tedeschi, con circa 4mila soldati, continueranno a presidiare il Nord e l'Ovest con programmi di formazione di esercito e polizia mentre britannici e americani restano un incognita. Quel che è certo è che termineranno le operazioni combat entro la fine del 2014 e si aprirà la nuova fase di Resolute Support. Quanto sarà risoluto resta da vedersi. Sul fronte della ricostruzione civile ci sono per ora promesse e fondi per altri quattro anni. Una riduzione dell'impegno civile rischia di compromettere definitivamente il rapporto col Paese che finirebbe per sentirsi definitivamente abbandonato anche sul piano dello sviluppo.
Il contenzioso con gli americani
I numeri del contingente americano non sono ancora definiti ma nel 2015 potrebbe trattarsi di circa 10mila uomini, molti dei quali sarebbero però impegnati nella difesa e tutela della basi militari di cui Washington vuole assicurarsi il controllo soprattutto in chiave anti iraniana. Ma al momento la firma definitiva dell'accordo tra le due capitali è ancora una nebulosa che dipende in sostanza, più che dalle basi, dalla richiesta di immunità per le truppe Usa su suolo afgano. Mal tollerata durante gli ultimi dodici anni, oggetto di polemiche continue, l'immunità è un nodo che per ora non si scioglie e da cui dipende la luce verde o meno all'accordo di partenariato militare (Bilateral Security Agreement - Bsa) che dovrà comunque passare per il parere di una Loya Jirga, la grande assemblea consultiva, che Karzai ha convocato in novembre e che finora è sempre servita a ratificare le scelte del presidente. Vi parteciperanno almeno 2.500 notabili.
Presidenziali
Il presidente Karzai, che in aprile dovrà ritirarsi, sta giocando le sue ultime carte su un tavolo dove il Bsa ha un peso rilevante. Si tratterebbe della sua ultima vera azione come uomo politico prima di lasciare per dedicarsi alla cura dell'uomo che avrà la presidenza e che il presidente uscente spera sia un personaggio di cui si fida e attraverso cui poter ancora esercitare influenza. Tra i numerosi candidati ce ne sono diversi su cui Karzai può puntare: sul fratello Qayum che non ha però molte speranze, su Ashraf Ghani e su Sayyaf. Ghani ha un passato specchiato ma non ha grande seguito né particolare influenza anche se è in ticket col potentissimo generale Dostum, un ex signore della guerra già ministro di Karzai e in grado di controllare una buona fetta dell'elettorato non pashtun nel Nord. Sayyaf è un altro ex signore della guerra, con relazioni forti in ambito tribale e una catena di rapporti personali estesa e potente. Ma sia Dostum sia Sayyaf sono anche personaggi impresentabili a un gran numero di afgani proprio per il triste e crudele passato che li accomuna. Dostum si è abilmente scusato pubblicamente e per altro le loro candidature hanno sollevato polemiche solo in Afghanistan. La comunità internazionale, come già in passato, ha chiuso un occhio. Il grande incomodo resta Abdullah Abdullah, nemico giurato di Karzai con forti relazioni nel Nord e buoni appoggi politici. E' stato sconfitto nelle passate elezioni a colpi di frodi elettorali. Difficile dire come andrà stavolta perché lo scrutinio si prevede più rigoroso e comunque sotto un occhio più vigile che in passato, sia all'interno sia all'esterno del Paese.
Governance

Chiunque vinca le elezioni si troverà di fronte a problemi enormi: quelli già citati, un'economia che dovrà riconvertirsi, il narcotraffico e, problema irrimandabile, la struttura della macchina pubblica, strangolata da una corruzione endemica che attraversa l'apparato a ogni livello e in tutti i gradi e settori in cui è attiva la mano pubblica, si tratti di ristrutturare una strada, aggiornare un catasto semi inesistente o di rilasciare una patente. La corruzione, un tempo accettata con rassegnazione, è adesso uno dei principali nodi del consenso interno. E dal momento che si coniuga con una macchina burocratica per molti aspetti ancora inefficiente, rischia di diventare il problema principale nel governo della cosa pubblica. La comunità internazionale ne ha fatto in passato un cavallo di battaglia che però ha semmai sfiorato i ministeri o le istituzioni bancarie ma non un problema culturale complesso nel quale è entrata a piè pari un'enorme massa di denaro, che ha favorito speculazioni e rapidi arricchimenti. Denaro fornito proprio dall'aiuto pubblico dei Paesi alleati e delle istituzioni internazionali, con scarsi o farraginosi meccanismi di controllo nonché episodi di appropriazione indebita o di favori alle proprie industrie nazionali che non hanno certo aiutato la costruzione di un modello virtuoso e di un esempio da imitare.
Economia
Inevitabilmente la guerra ha finito per drogare l'economia afgana, praticamente inesistente quando nel 2001 iniziò il conflitto con quel che restava dell'emirato di mullah Omar. L'aiuto esterno costituisce oltre il 90% del Pil e gli introiti dell'economia sommersa (in gran parte legata al narcotraffico) sarebbero valutati a circa la metà della ricchezza legalmente a bilancio. Inoltre, l'enorme massa di valuta pregiata entrata in Afghanistan ha finito per rafforzare l'afghanis su dollaro e euro rendendo molto più competitiva l'offerta dei paesi vicini, che hanno svalutato mediamente del 40% le loro divise. Con un export in deficit, un'economia formale sovvenzionata, un'agricoltura arretrata e quasi la totale assenza di prodotti industriali, l'Afghanistan deve inoltre fare i conti con l'ingresso annuale di circa 400mila giovani nel mercato del lavoro, dominato dal lavoro informale stagionale e privo di tutele sindacali. Problema probabilmente sottostimato, il nodo della riconversione da un'economia drogata dalla guerra a un'economia che dovrà camminare a breve sulle sue gambe sta ora arrivando al pettine
Quadro regionale
La pace in Afghanistan non si può fare senza l'aiuto, la non ingerenza o quantomeno la non ostilità dei suoi vicini. I passi per un'alleanza regionale sono stati tardivi e sono al momento ancora troppo pochi e del tutto fragili. Il cosiddetto Processo di Istanbul, avviato due anni fa, avrebbe probabilmente dovuto iniziare molto prima e forse accompagnarsi a una revisione del mandato delle truppe che stazionavano e stazioneranno in Afghanistan. I due livelli invece sono sempre stati tenuti separati, come se non fossero la faccia della stessa medaglia. Il processo di integrazione è comunque avviato pur se dipende da numerosi fattori endogeni (la diffidenza degli afgani verso Islamabad, Teheran e Mosca) ed esogeni, il primo dei quali è l'agenda geopolitica delle singole nazioni.
Anche su
Aspenia